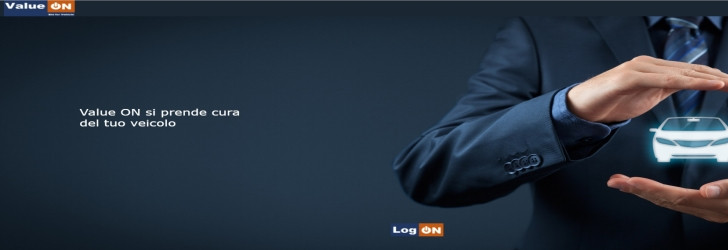- Fashion
Tra noleggio e second hand, il ruolo dei consumatori per cambiare la moda 'insostenibile'
Welchman (Ubp), investitoru possono guidare i capitali verso la soluzione dei problemi
I miglioramenti nelle fasi di produzione, consumo e fine vita della catena del valore dell'abbigliamento potrebbero portare a un risparmio di circa 160 miliardi di euro all'anno, rendendo allo stesso tempo più efficiente l'uso di energia e acqua da parte dell'industria, così come le pratiche lavorative. Lo rileva Rupert Welchman, Portfolio Manager Impact Equities di Union Bancaire Privée, sottolineando però come un ruolo cruciale lo possono rivestire i consumatori. I più giovani lo hanno capito. Tant'è che spesso adottano stili di consumo come il noleggio o il second hand. L’industria della moda, d'altra parte, negli ultimi decenni, è stato considerata un esempio estremo di insostenibilità: oggi però c’è una consapevolezza più diffusa e c'è volontà di cambiare. In questo senso, gli investitori hanno un ruolo chiave nella trasformazione e possono guidare i capitali verso la soluzione dei problemi.
"In questi giorni - sottolinea Welchman - si parla molto dell’importante carbon footprint dell'industria dell'abbigliamento. La supply chain tradizionale di questa industria conta diverse problematiche: impoverimento delle risorse naturali, inquinamento, uso massiccio di energia, emissioni di gas serra. Per non parlare dei dati sul lavoro sottopagato e persino minorile, sull'occupazione precaria e sulle condizioni di lavoro malsane o non sicure. Nello tentativo costante di tenere alti i consumi e abbassare i prezzi, il fast fashion è stato un business affamato di risorse ma ora è tempo che il settore dell'abbigliamento ripensi non solo i suoi processi, ma l’intera filosofia e la sua ragion d'essere". Una preoccupazione chiave è ovviamente "l'impatto dei materiali usati per la produzione di tessuti. La produzione del cotone, che pure è un materiale naturale, biodegradabile e riciclabile, richiede un'enorme quantità di acqua e terra. Il poliestere, la fibra sintetica più comunemente usata per fare vestiti, consuma meno acqua e genera meno rifiuti delle fibre naturali, ma non è biodegradabile e, quando viene lavato, rilascia microplastiche che finiscono nei fiumi e negli oceani e danneggiano la vita marina, danneggiando in ultima istanza l'intero ecosistema di cui anche noi facciamo parte". Ora, nel mercato delle eco-fibre, da 37,3 miliardi di franchi svizzeri, sempre più imprenditori stanno lavorando per produrre fibre alternative come la canapa e la pasta di legno, ma anche fondi di caffè e alghe. Si stanno facendo sforzi, evidenzia l'esperto, per riciclare anche le fibre sintetiche, come il Pet, per produrre articoli come borse e scarpe. "Affinché l'industria della moda diventi circolare, bisogna inglobare la scelta in favore di queste alternative già nella progettazione stessa degli indumenti, sin dal momento della concezione, tenendo presente l'intero ciclo di vita del prodotto, compreso il suo eventuale smaltimento".
Però serve anche un cambiamento di mentalità anche tra i consumatori: "negli ultimi 15 anni il tasso di utilizzo dei vestiti è calato del 36%, scendendo a soli 10 utilizzi per capo. Secondo Euromonitor International, ogni persona in media acquista 15 capi e due paia di calzature ogni anno. Se siamo disposti a spendere di più per ogni articolo, pagando per la qualità piuttosto che per la quantità, e conservando e indossando i nostri vestiti più a lungo, noi consumatori possiamo avere un impatto enorme". Welchman segnala anche che tra i giovani, un maggiore interesse verso il mercato dei beni di seconda mano e del noleggio. La medesima tesi emerge da uno studio condotto dai ricercatori della Washington State University e pubblicato sulla rivista Sustainability che considera la Gen Z. Il 55% di essa ha già sperimentato il noleggio nel settore moda, con le donne maggiormente coinvolte dalla tendenza. “Il 25% del nostro fatturato arriva proprio dalla Generazione Z, segno dell’interesse di questa fascia d’età nei confronti del noleggio. I giovani hanno sposato la nostra filosofia e compreso come il fashion renting possa rivelarsi un’ancora di salvezza e contribuire a un futuro più verde, fatto di capi in grado di durare nel tempo e di guardaroba infiniti e condivisi – afferma Caterina Maestro, fondatrice e Ceo della startup milanese DressYouCan.
Ma qual è la leva principale di questo cambiamento culturale che interessa soprattutto i nati tra il 1995 e il 2010? La sensazione di fare la differenza. Una svolta più che necessaria se si pensa che, secondo l’Environmental Protection Agency, nel 2018 negli Stati Uniti oltre 17 milioni di tonnellate di tessuti sono finiti nelle discariche. Un aumento drammatico paragonato alle circa 13 milioni di tonnellate nel 2009 e ai 9,4 milioni di tonnellate nel 2000. Inoltre, secondo Clean Clothes Campaign, nei paesi occidentali in media ogni persona produce 70 kg di rifiuti tessili all’anno che rappresentano il 5% degli scarti prodotti a livello globale. Oltre alle conseguenze ambientali, i giovani sono più sensibili anche verso l’etica lavorativa dell’industria, un elemento spesso trascurato dalle grandi marche che fanno dei capi usa e getta il loro credo: come evidenziato da Fast Company, infatti, lo stipendio medio di una persona che in Bangladesh si occupa di creare le magliette indossate in Europa e America è di 28 taka all’ora (pari a 28 centesimi di euro), cifra che lo porta a faticare per riuscire a pagare le bollette anche lavorando 60 ore a settimana. La situazione non è diversa in Cambogia dove il salario è di circa 70 centesimi l’ora o in India dove si scende addirittura a 49.